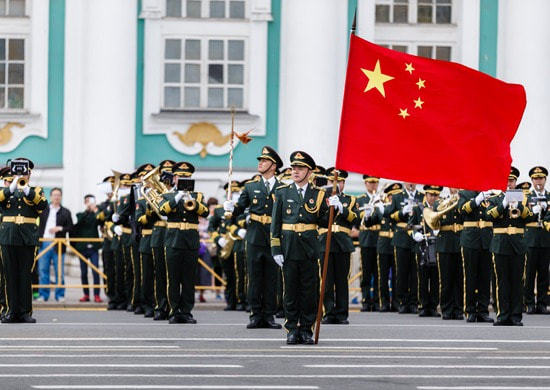Deterrenza allo spillover terroristico: come cambia la Cina di fronte agli sviluppi in Afghanistan30/12/2021
a cura di Enrico Bruni A seguito del deterioramento dei rapporti sino-sovietici, negli ultimi decenni dello scorso secolo la Repubblica Popolare Cinese ha gradualmente posto maggiore attenzione alla situazione sul confine afgano. Sebbene esso rappresenti il confine più circoscritto dello Stato cinese, le autorità hanno fin da subito riscontrato un potenziale pericolo per la propria sicurezza nazionale in quella che appariva come una riproposizione della politica Breznev al di là dei confini asiatici. All’indomani della penetrazione sovietica nei territori afghani nel dicembre 1979, l’obbiettivo da parte di Pechino si concentrò sul limitare le mire egemoniche dell’imperialismo sovietico in Asia Centrale, sfruttando la resistenza degli autoctoni per contenere le mire di Mosca. Pechino, del resto, si trovava ad affrontare in quel momento una seconda crisi al di fuori dei propri confini: nel febbraio dello stesso anno, infatti, la RPC si era attivamente impegnata nel conflitto cambogiano-vietnamita a fianco della Kambuchea Democratica, in quello che si impose come uno scontro tra opposti marxismi, a trazione cinese – da un lato – e russa – dall’altro. Così l’Esercito Popolare di Liberazione fu coinvolto nell’addestramento dei ribelli afgani, svolgendo da una parte il ruolo di alleato strategico di Washington, dall’altra quello di interlocutore credibile con i mujahidin afgani, con l’obbiettivo di dissuaderli dal tessere rapporti con le forze separatiste di etnia uigura che operavano nei territori dello Xinjiang. Con la ritirata delle truppe sovietiche dieci anni più tardi, le preoccupazioni da parte di Pechino non cessarono a causa dell’imminente guerra civile e della conseguente anarchia nel mercato di armi e droghe che aveva il suo centro in Afghanistan. Negli anni ’90 il governo cinese fu costretto a ricalibrare la propria diplomazia nei confronti dello Stato talebano, in quanto la strategia di isolamento delle cellule uigure non aveva avuto l’effetto desiderato: l’Afghanistan del Mullah Omar era divenuto infatti terra di rifugio per combattenti stranieri e la Cina vedeva adesso al di là del Corridoio del Wakhan una possibile base di lancio per attentati terroristici sul proprio suolo. Dopo gli avvenimenti dell’11 settembre l’esigenza di una campagna internazionale contro il terrorismo si fece sempre più forte. Temendo quello che potremmo definire un effetto spillover del terrorismo internazionale, Pechino si allineò alla volontà statunitense di risolvere definitivamente la “questione islamica”. Così il dialogo sino-statunitense, iniziato con la concessione del voto cinese alla Risoluzione 1368 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sull’autorizzazione all’uso della forza, si concentrò sull’individuare strategie coordinate per la deterrenza al terrorismo. È in questo contesto internazionale che vengono rafforzate legislazioni domestiche come la Strike Hard Campaign: varata nel 1996 come operazione di polizia di portata nazionale, questa si vide proiettata sui più complessi scenari del terrorismo transnazionale, accentuando la sua accezione di “hard campaign” a fronte di episodi di violenza che miravano ad alterare determinate politiche statali in particolari aree geografiche dove erano presenti minoranze, prima tra tutte lo Xinjiang. Sul versante regionale, invece, la situazione in Asia Centrale consolidò i rapporti tra i paesi che avevano aderito al meccanismo di cooperazione multilaterale Shanghai Five (1996), concorrendo in tal modo alla sua trasformazione nello Shanghai Cooperation Organisation all’inizio del nuovo millennio. La Cina si interfacciò, inoltre, come partner strategico per tutti quei paesi con cui condivideva interessi in sviluppo economico e sicurezza interna, promuovendo nuovi accordi bilaterali di cooperazione con gli Stati confinanti. Oggi, dopo la caduta del National Unity Government dell’Afghanistan e la conseguente decadenza di quegli impegni internazionali sul tema della deterrenza concordati da un rinnovato rapporto sino-afgano, le autorità della RPC valutano gli sviluppi regionali in Afghanistan con grande attenzione, proponendo una diversa visione di “stabilità” rispetto a quella americana. Se da una parte la Cina deve fare i conti con le ambizioni di Pakistan e Russia, dall’altra parte la propria posizione è ben diversa rispetto a quella degli anni ’80 e il ruolo che può oggi esercitare non si limiterà alla sola strategia di contenimento applicata durante la penetrazione sovietica. L’obbiettivo resta quello di stabilizzare i propri confini e la propria sicurezza interna, in linea con quella che è la “regola aurea” della diplomazia cinese: il principio di non ingerenza. In questo quadro, tuttavia, la volontà di Pechino non è soltanto strategico-militare. A fianco al desiderio di un Afghanistan stabilizzato e cooperativo, la possibilità di allontanare le autorità afghane dall’area di influenza statunitense apre nuove prospettive per lo sviluppo di infrastrutture lungo la rotta terrestre della Belt and Road Initiative. L’elemento di novità rappresentato dall’unicità di un rinnovato Stato talebano pone la Cina di fronte alla possibilità di ampliare ulteriormente la propria sfera di influenza regionale. Ciò le consentirebbe non soltanto di alterare gli equilibri regionali a scapito di India e Pakistan, ma anche l’accesso alle risorse minerarie presenti nel sottosuolo afghano, particolarmente interessanti nella contesa per il primato sulle terre rare.
|
|
||||||