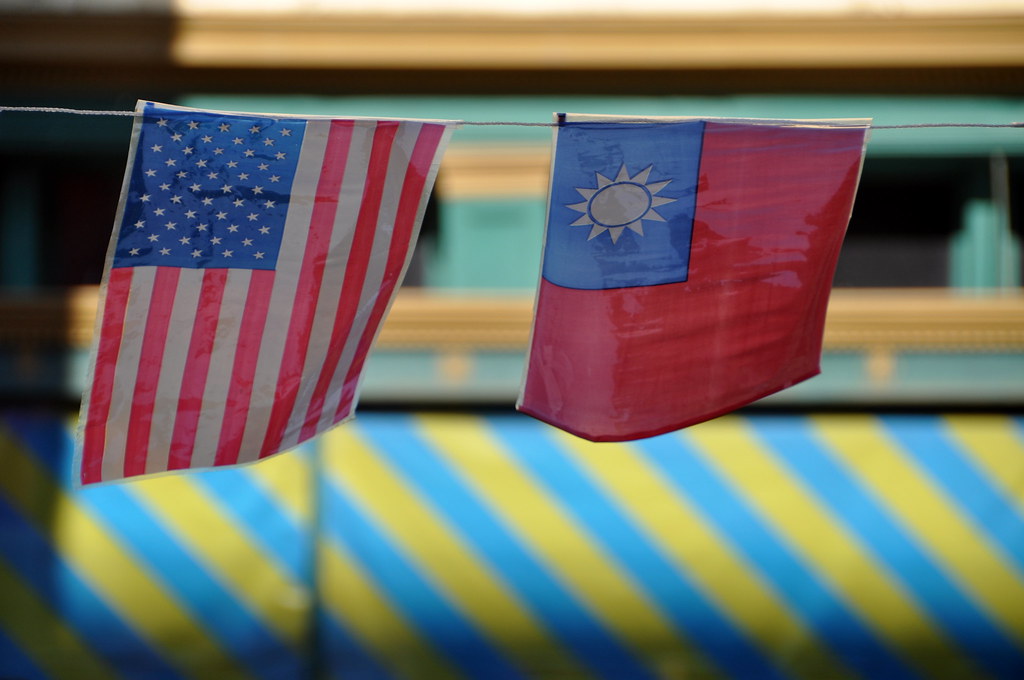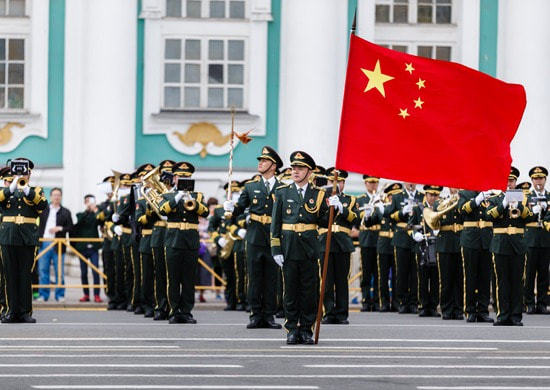|
A cura di Vittorio Ruocco, Osservatorio sulla politica estera italiana
Dal 1946 ad oggi, la storia dell’Italia repubblicana ha attraversato, ormai, diversi passaggi istituzionali, ciascuno dei quali ha reso evidente quali esponenti politici fossero titolari di quell’”arte della misura” di cui Platone parla nel suo Politico. Alleanze, consultazioni e appoggi politici, più o meno manifesti, hanno sempre caratterizzato la politica italiana, spesso guadagnandosi il disprezzo di un’opinione pubblica sempre più desiderosa di certezze. La condivisione mediatica di queste elezioni presidenziali – forse tra le più seguite – ha mostrato quanto alla base delle decisioni politiche ci sia semplicemente il dialogo, le cui forme assume di volta in volta significati differenti, spesso ambigui e finanche incomprensibili fuori dalla Penisola. Sono numerosi[1], infatti, gli articoli della stampa estera che descrivono come e perché si elegge il presidente della Repubblica Italiana. Il riflesso di una particolare attenzione di tutti: compagini europee, alleati atlantici e importanti partners commerciali. Questa volta, l’analisi degli scrutini si è spinta oltre la frammentazione partitica nel Paese, considerando gli scenari possibili alla luce anche del contesto internazionale, particolarmente infiammato per l’intensificazione di una tensione tanto recente quanto antica: Stati Uniti e Russia, sostenuti dai propri Paesi alleati e satelliti, su un fronte che non assisteva a quest’escalation da ormai un po’ di decenni. Un’Europa orientale che pian piano si è avvicinata a Bruxelles e a Washington, senza poter abbandonare le proprie radici culturali e storiche che la legano a Mosca. Anche il discorso per il nuovo settennato del XII Presidente della Repubblica Italiana, tenuto il 3 febbraio scorso dinanzi al Parlamento in seduta comune, ha una chiara connotazione internazionale: dal singolare saluto di cortesia al Corpo Diplomatico accreditato fino all’appello da rivolgere ai Paesi alleati per un dialogo di pace; dal riconoscimento dell’ingannevole efficienza dei regimi autoritari fino alla conferma dell’adesione italiana ai principi dell’atlantismo e dell’europeismo. I riferimenti tengono ovviamente considerazione della convinzione statunitense del “ruolo critico dell’Italia, della NATO e dell’Unione Europea nel garantire la sicurezza del continente”[2], soprattutto nell’attuale congiuntura diplomatica tra Russia e il fronte UE/USA sulle manovre militari prossime al confine con l’Ucraina. Non sarà fortuito l’incontro tra l’Incaricato d’Affari statunitense in Italia Thomas Smitham con l’Ambasciatore ucraino a Roma Yaroslav Melnyk, come non lo sarà il successivo colloquio telefonico tra il Presidente del Consiglio Mario Draghi e il Presidente della Federazione Russa Vladimir Putin qualche ora più tardi. La diplomazia, si sa, è l’incrocio di conversazioni e dialoghi di parti diverse, ciascuna interessata a garantire i propri interessi all’ombra dei riflettori. L’Italia sembra essere il giusto terreno di scontro per entrambe le parti: da un lato, infatti, Roma resta l’unica capitale europea a non vedersi accreditato un capo missione statunitense col rango di ambasciatore[3], permettendo lo svolgimento di colloqui certamente più informali; dall’altro, lo Stivale vanta “una consolidata tradizione di rapporti complessi e multiformi con questo grande Paese”[4] – cioè la Russia – caratterizzato da una considerevole importazione di metri cubi di gas, anche nell’attuale fase di inflazione e di aumento dei prezzi dell’energia. Una realtà che non è affatto sfuggita al Presidente Putin che lo ha ricordato nell’incontro con gli imprenditori italiani lo scorso 26 gennaio. È proprio nella Città Eterna che si è realizzato un braccio di ferro diplomatico USA-Russia, invisibile acceleratore delle elezioni presidenziali italiane per una garanzia di stabilità del Paese. Prontamente riportato da Formiche.net[5], nel pieno delle consultazioni tra i più importanti esponenti politici del Paese per l’elezione di una personalità dall’alto profilo alla prima carica dello Stato, il 21 gennaio scorso l’ambasciata statunitense in Italia pubblicava un documento dal titolo “How Russia conducts false flag operations”, nel quale Palazzo Margherita ha citato le manovre russe all’epoca dei disordini in Georgia nel 2008 e dell’”intervento di autodifesa” in Crimea nel 2014. La risposta russa non si è fatta attendere molto. Dal titolo “La “falsa bandiera” degli USA” e pubblicato il 27 gennaio, l’ambasciata russa in Italia ha voluto ricordare i casi in cui gli Stati Uniti hanno adottato condotte controverse per raggiungere taluni obiettivi militari, come, tra le altre, nel caso dell’incidente nel Golfo del Tonchino del 1964 oppure del rapimento di Abu Omar a Milano nel 2003. Il fine comunicativo di questi due documenti, apparentemente inquadrabili in un contesto di semplice conflittualità, risulta non essere lo stesso per entrambe le parti se si considera che il comunicato russo, diversamente da quello statunitense, è stato pubblicato in lingua italiana, probabilmente anche per raggiungere il pubblico italofono, oltre che rispondere alla controparte oltreoceano. Fatti, questi, che riflettono come l’escalation dell’opposizione russo-americana sulla questione ucraina possa inserirsi in un panorama già di per sé incerto a causa dell’importante scadenza elettorale, esponendolo ad influenze non solo politiche ma anche economiche. Il giorno del primo scrutinio, il 24 gennaio, due fatti sono stati riportati dalla stampa italiana. Mentre Piazza Affari scambiava in pesante ribasso[6], il gruppo svizzero MSC e la compagnia tedesca Lufthansa presentavano una manifestazione d’interesse per l’acquisizione della maggioranza della nuova compagnia di bandiera Ita Airways, non senza suscitare qualche reazione avversa[7] [8]. Non solo, anche il settimanale inglese The Economist è entrato a gamba tesa nelle consultazioni partitiche nostrane, schierandosi apertamente contro una possibile elezione di Draghi al Palazzo del Quirinale, così come il celebre The New York Times aveva già riconosciuto che il caos politico intorno al futuro del capo del governo avrebbe potuto spingere l’Italia verso un “pericoloso, se non familiare, precipizio di instabilità”. Articoli e notizie, queste, che hanno inevitabilmente alimentato la caratteristica confusione sociale, economica e politica legata al rinnovo di un mandato, specialmente se è interessata la prima carica dello Stato. Malgrado la sua eccezionalità costituzionale, la rielezione del Presidente Mattarella segna, finalmente, la continuazione di un percorso di stabilità politico-istituzionale, in una cornice internazionale certamente instabile. Che l’Italia avrà un ruolo di mediazione e di influenza non è assolutamente escluso. Il suo ruolo di Paese fondatore dell’Unione Europea e la tradizionale linea politica del compromesso, capisaldi della politica estera italiana, potrebbero permettere, in questa fase, di abbandonare la tradizionale ombra dai riflettori e acquisire maggiore influenza. [1] Per citarne due: CARLO, A. «Explained: The mystery and quirks of Italy’s presidential elections», Euronews, 24 gennaio 2022. Disponibile su: https://www.euronews.com/my-europe/2022/01/24/silvio-berlusconi-and-the-mystery-of-italy-s-presidential-election (consultato il 15/02/2022) e LEALI, G., « Putin serenades Italy Inc. amid Ukraine crisis», Politico, 25 gennaio 2022. Disponibile su: https://www.politico.eu/article/vladimir-putin-russia-italy-business-ukraine-crisis/ (consultato il 21 febbraio 2022) [2] US Mission in Italy, Dichiarazione del Portavoce del Dipartimento di Stato Ned Price sulla telefonata del Segretario Blinken con il Ministro degli Esteri italiano Di Maio. 19 gennaio 2022, URL: https://it.usembassy.gov/it/dichiarazione-del-portavoce-del-dipartimento-di-stato-ned-price-sulla-telefonata-del-segretario-blinken-con-il-ministro-degli-esteri-italiano-di-maio/ (consultato il 4 febbraio 2022) [3] LICONTI, M., L'Italia aspetta ancora l'ambasciatore Usa, 'non escluso arrivo in primavera', «Adnkronos», 11 gennaio 2022. URL: https://www.adnkronos.com/litalia-aspetta-ancora-lambasciatore-usa-non-escluso-arrivo-in-primavera_7mj4Qs5jzm95vxjC9GvZsB (consultato il 4 febbraio 2022) [4] CIRCOLO DI STUDI DIPLOMATICI (2019), “Le relazioni euro-russe e il ruolo dell’Italia” in Dialoghi Diplomatici, n° 240, 25 febbraio 2019. Disponibile su: https://www.esteri.it/it/ministero/sindacati-e-associazioni/circolo-di-studi-diplomatici-pubblicazioni-2019/ (consultato il 6 febbraio 2022) [5] CARRER, G. Infowar sull’Ucraina a Roma. Scontro diplomatico Usa-Russia, «Formiche.net», 28 gennaio 2022. URL: https://formiche.net/2022/01/scontro-diplomatico-usa-russia-a-roma/ (consultato il 4 febbraio 2022) [6] BORSA ITALIANA, 1 minuto in borsa 24 gennaio 2022 in “Teleborsa”, 24 gennaio 2022. URL: https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/teleborsa/economia/1-minuto-in-borsa-24-gennaio-2022-5_2022-01-24_TLB-VIDEO.html?lang=it (consultato il 4 febbraio 2022) [7] DELLI COLLI, L. Ita, Lufthansa conferma le trattative in corso. Rampelli: «Diventerà una low cost tedesca», «Secolo d’Italia», 25 gennaio 2022. URL: https://www.secoloditalia.it/2022/01/ita-lufthansa-conferma-le-trattative-in-corso-rampelli-diventera-una-low-cost-tedesca/ (consultato il 4 febbraio 2022) [8] Per approfondire gli aspetti positivi di tale operazione, v. CASCETTA E. e MARZANO V., La logica (e la logistica) di un accordo tra Msc, Lufthansa e Ita Airways, «Il Sole 24 Ore», 1° febbraio 2022. URL: https://www.ilsole24ore.com/art/la-logica-e-logistica-un-accordo-msc-lufthansa-e-ita-airways-AEQJ0HBB (consultato il 4 febbraio 2022) a cura di Giorgio Catania Dopo la fine della Guerra Fredda, la Russia – anche perché troppo debole – ha accettato una riduzione della sua sfera di influenza. Lo dimostrano la prima espansione della NATO verso est nel 1999 (Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria, Bulgaria) e la seconda nel 2004 (Estonia, Lettonia, Lituania, Slovacchia, Slovenia, Romania). Oggi il Cremlino, di fronte ad una possibile inclusione di Kiev nell’Alleanza Atlantica, ha tracciato una linea rossa: l’Ucraina non si tocca. Putin mira, infatti, a ricostruire una sfera di influenza nell’est Europa e vuole che l’Ucraina continui ad essere uno stato “neutrale”, uno spazio-cuscinetto tra il blocco della NATO e la Russia. Un eventuale ingresso dell’Ucraina nella NATO porterebbe l’Occidente sulla porta di casa della Russia e, agli occhi del Cremlino, rappresenterebbe una minaccia molto grave alla sicurezza. Ma quante possibilità ci sono che l’Ucraina entri nell’Alleanza Atlantica? La risposta è arrivata da Joe Biden: “Le possibilità che l’Ucraina si unisca alla NATO in tempi brevi è molto remota”. A prescindere dalle pretese di Putin, la NATO non potrebbe ammettere nuovi membri già coinvolti in conflitti. Inoltre, Kiev dovrebbe dar vita ad un percorso di riforme politiche e militari. Nonostante le rassicurazioni ed il fatto che solo il 6% dei confini russi tocchi i paesi della NATO, Vladimir Putin ha deciso di esercitare una pressione militare imponente sull’Occidente. Da tempo ha infatti ammassato più di 100.000 soldati al confine con l’Ucraina ed avanzato una serie di richieste a NATO ed USA: la garanzia che l’Ucraina resti fuori dalla NATO; l’interruzione di tutte le esercitazioni militari in Europa orientale, nel Caucaso e nell’Asia centrale; il ritiro di tutte le forze militari dei paesi NATO da vari paesi dell’Europa centrale e orientale. La strategia di Putin puntava a lanciare un segnale. Le richieste di Mosca sono ritenute inaccettabili da Washington, che difende il principio secondo cui ogni Paese ha il pieno diritto di definire la propria politica estera e le proprie alleanze liberamente. Nell’eventualità di una possibile invasione e l’arrivo di forze russe ai confini dei paesi NATO, gli Stati Uniti hanno inviato 3.000 soldati in Polonia, Germania e Romania mentre l’Alleanza ha inviato navi da guerra ed aerei per implementare la capacità di deterrenza e difesa di fronte all’aggressività del Cremlino. Sono stati messi in stato di allerta 8500 soldati statunitensi. Biden sta inoltre mettendo a punto le “sanzioni più imponenti di sempre”. Si parla di escludere la Russia dal sistema bancario internazionale Swift, utilizzato da oltre 11mila istituti finanziari in oltre 200 paesi. La Casa Bianca starebbe pensando di limitare le esportazioni di componenti elettroniche e microchip in Russia e di colpire funzionari del governo russo e leader militari. Potrebbe essere un bersaglio lo stesso Putin, a cui verrebbero congelati gli asset finanziari o addirittura impediti i viaggi al di fuori dei confini russi. E poi c’è la questione del gas russo, di cui gran parte dei paesi europei è dipendente. Il gasdotto Nord Stream 2, che attraverso il Baltico collega Russia e Germania, non è ancora stato completato. Il cancelliere tedesco Scholz si è dichiarato disponibile a bloccare il progetto in caso di invasione dell’Ucraina (cosa avvenuta all’indomani della decisione russa di riconoscere le repubbliche separatiste e inviare truppe regolari in loro sostegno). Da sempre gli Stati Uniti si oppongono a Nord Stream 2, temendo che l’Europa diventi troppo dipendente da Mosca dal punto di vista energetico. Se da una parte il Regno Unito condivide la linea dura USA, dall’altra la Germania si è posta come capofila dei paesi prudenti. Berlino soddisfa infatti il 49% del suo fabbisogno di gas con le importazioni dalla Russia. Poco dietro c’è l’Italia, con il 47%. Sono addirittura più esposti alle forniture russe paesi europei come Finlandia, Lettonia (oltre il 90%) ed Austria (65%). Più defilata la Francia (poco meno del 25% grazie alle centrali nucleari). Così come l’Europa dipende dal gas russo, allo stesso modo la Russia dipende dal mercato europeo. Basti pensare che il bilancio statale di Mosca dipende per il 40% dalle vendite di idrocarburi (gas e petrolio) all’Europa. Stando ai dati raccolti dall’Economist, se Mosca – per ritorsione – dovesse sospendere i flussi di gas arriverebbe a perdere tra i 200 e i 228 milioni di dollari al giorno. Se il blocco durasse tre mesi (in primavera la domanda di gas si riduce notevolmente), le perdite per Gazprom ammonterebbero a 20 miliardi. La Russia, tuttavia, avrebbe le capacità per resistere diversi mesi e compensare il danno economico. Negli ultimi anni Vladimir Putin ha corazzato la Russia di fronte alla possibilità di nuove sanzioni europee ed americane. La Banca Centrale russa detiene infatti circa 600 miliardi di riserve in oro e dollari, il debito pubblico e privato è ai minimi e l’abbandono del dollaro è in fase avanzata (le riserve in dollari sono crollate dal 50% del 2018 al 16% attuale a vantaggio di euro e yuan). Tutto ciò senza contare l’importanza economica e strategica che avrebbe un’alleanza sempre più stretta tra Russia e Cina.
a cura di Elisa Cecchini La Russia di Vladimir Putin si sente accerchiata e minacciata alla sua sicurezza, dopo aver ceduto, negli scorsi decenni, la propria influenza in aree di interesse geopolitico di enorme valore. Da mesi ormai le attenzioni della politica internazionale sono rivolte verso l’Europa orientale, in cui è in atto la più grande crisi dai tempi della Guerra Fredda. Dalla primavera dello scorso anno, la Russia ha iniziato a muovere le truppe concentrandole al confine con l’Ucraina, inviando progressivamente forze armate in Bielorussia e dispiegando la sua flotta militare nel Mar Nero, ufficialmente per esercitazioni. Questi movimenti di forze armate hanno causato tensioni con l’Occidente, preoccupato per un’imminente invasione dell’Ucraina. Bisogna però fare un passo indietro per capire la crisi attuale, a quando la Guerra Fredda stava per giungere alla sua conclusione. Da più di due decenni, la Russia sostiene che durante i negoziati sulla riunificazione tedesca del 1990, gli Stati Uniti avessero promesso che la NATO non si sarebbe espansa verso l’Europa orientale. Gli Stati Uniti hanno sempre negato che ciò sia accaduto, ma su un punto gli studiosi occidentali concordano: il 9 febbraio 1990, il Segretario di stato americano James Barker rassicurò Gorbachev e Eduard Shevardnadze, Ministro degli esteri sovietico, sul fatto che non ci sarebbe stato nessun allargamento dell’Alleanza verso est, “nemmeno di un centimetro”. Invece la NATO è stata rafforzata, allargandosi di almeno mille chilometri verso est: In passato aveva solo una piccola frontiera con la Russia, all’estremo nord della Norvegia, oggi invece l’Alleanza comprende sette stati dell’ex Patto di Varsavia, più le tre repubbliche baltiche. Negli anni Novanta, La Russia indebolita di Boris Eltsin non riuscì a contrastare questo progetto d’allargamento dell’Alleanza. Il punto di svolta arrivò nel 2007, con il celebre discorso di Putin alla Conferenza di Monaco sulla Sicurezza, che segnò la progressiva rotta che avrebbero preso le relazioni della Russia con gli Stati Uniti e la NATO. In quel discorso, Putin espresse con forza la sua opposizione all’ordine internazionale sorto dalle macerie della Guerra Fredda, a guida statunitense, e al mancato rispetto della parola data di quest’ultimo, permettendo l’allargamento a est dell’Alleanza. Durante il summit della NATO di Bucarest dell’anno successivo, nonostante le perplessità di una parte della “vecchia Europa”, sotto pressione americana, si dichiarò che l’Ucraina e la Georgia sarebbero entrati nell’Alleanza in tempi e modalità da definire. Mosca rispose che nel caso in cui Kiev e Tbilisi fossero entrati nella NATO, si sarebbe trovata costretta a compiere “passi concreti per difendere i propri interessi” prendendo misure a tutela della propria sicurezza, “anche di carattere militare”. Il discorso di Putin a Monaco ha segnato la fine del ruolo modesto che la Russia ha giocato nei decenni post-Guerra Fredda; quel ruolo, infatti, è stato completamente messo da parte con la crisi ucraina del 2013 culminata con l’occupazione e l’annessione della Crimea. Le tensioni militari odierne sono solo l’atto più recente del conflitto ucraino che ormai perdura da otto anni. Nel novembre 2013, le proteste di Euromaidan a Kiev portarono alla deposizione del leader filorusso Viktor Janukovyc, all’indomani della sospensione dell’accordo di associazione che costituiva una zona di libero scambio (DCFTA), tra Ucraina e Unione europea. Le contro-proteste scoppiate nelle regioni orientali dell’Ucraina a maggioranza russofona, secondo alcuni fomentate dal Cremlino, portarono Mosca a volgersi verso due principali teatri geopolitici ucraini. Il primo fu quello della Crimea, che nel 1954 fu regalata all’Ucraina dall’allora Segretario del partito comunista Nikita Crushchev in occasione del tredicesimo anniversario degli accordi di Pereyaslav. Nel 2014, con l’appoggio unanime del Consiglio della Federazione Russa, Mosca occupò la penisola e indette un referendum sull’autodeterminazione della Crimea, illegittimo per la comunità internazionale, a cui seguì l’annessione alla Federazione Russa. Il secondo teatro verso cui si volse Mosca, fu la regione filorussa del Donbass, la cui secessione portò a compimento la vocazione indipendentista di Donec’k e Luhans’k. Questo diede inizio al conflitto territoriale tra le repubbliche separatiste, appoggiate da Mosca, e il governo centrale ucraino. Il presidente russo Putin ha tratto vantaggio dalle tensioni tra le forze governative e separatiste del sud-est ucraino, che gli hanno permesso di rafforzare la propria posizione nella regione e di usare il momento per regolare i conti in sospeso con la NATO. Nell’aprile 2021, secondo le dichiarazioni di Jospeh Borell, Alto rappresentante dell’Unione europea, almeno 150000 soldati russi sono stati dispiegati in una esercitazione militare al confine ucraino. Negli scorsi mesi il progressivo accumulo di truppe al confine ha fatto accrescere i sospetti dell’Occidente su una possibile azione militare. Ma quello che vuole Mosca sono garanzie di limitazioni delle azioni NATO: a dicembre sono state presentate due bozze che contenevano richieste di “garanzie di sicurezza” indirizzate agli Stati Uniti e alla NATO. Mosca chiede un consistente arretramento della NATO, portando le forze dell’Alleanza nella posizione del 1997, e la creazione di una sfera d’influenza russa in Europa orientale, nel Caucaso e nell’Asia Centrale, in pratica nell’ex spazio sovietico. In particolare, la NATO non sarebbe solo obbligata a escludere ulteriori espansioni, ma anche a rinunciare a qualsiasi cooperazione militare con l’Ucraina. Inoltre, la NATO non potrebbe schierare truppe o armamenti in Europa orientale, e sarebbe quindi costretta a ritirare il piccolo contingente dispiegato in Polonia e negli stati baltici a seguito dell’invasione russa della Crimea. La via diplomatica e di dialogo non ha prodotto passi concreti verso una soluzione della crisi ucraina come si è visto dall’incontro bilaterale russo-statunitense svoltosi a Ginevra e quello successivo tra Russia e NATO a Bruxelles. I vertici dell’Alleanza però si sono detti disponibili a discutere nuovi limiti sui missili e sulle esercitazioni militari in Europa. La situazione però non si è acquietata, anzi, in seguito all’annunciata esercitazione congiunta “Allied Resolve” tra Russia e Bielorussia, che ha alimentato le preoccupazioni di Kiev circa una possibile invasione via Bielorussia, si è aggiunto l’allarmismo dell’intelligence statunitense, secondo cui un’invasione russa era ormai imminente. La Casa Bianca pur avendo pubblicamente dichiarato di non essere sicura che la decisione fosse stata presa, han ribadito che la strada del dialogo con Mosca rimane aperta. Questa svolta nel conflitto in corso ha portato a una improvvisa e violenta escalation. Gli Stati Uniti hanno evacuato gran parte del corpo diplomatico presente a Kiev, annunciando la sospensione di tutti i servizi consolari. I paesi dell’Ue hanno mantenuto una linea più morbida, consigliando ai propri cittadini in Ucraina, il ritorno in patria tramite vie commerciali, lasciando comunque aperte ambasciate e sedi consolari. Il presidente ucraino Volodymyr Zelens’kyj ha invitato a mantenere la calma, non essendoci nessuna prova fondata pervenuta al governo ucraino in merito ad un attacco imminente. L’Occidente non ha però accolto questa richiesta e i media statunitensi hanno continuato quella che è a tutti gli effetti un’offensiva mediatica. Con la decisione del 21 febbraio di riconoscere le due repubbliche separatiste, la Russia ha ordinato alle proprie truppe di entrare nei territori contesi per proteggere le popolazioni russofone, aprendo la strada a possibili scontri con le forze ucraine, con lo spettro di un conflitto su larga scala dietro l’angolo che si manifesta in maniera sempre più evidente. A prescindere dalla conclusione della vicenda, l’odierna crisi ucraina ha già sostanzialmente modificato gli equilibri internazionali in maniera determinante.
a cura di Gianluca Maglione Martedì 25 gennaio il Governo polacco ha dato il via alla realizzazione del muro lungo il confine est con la Bielorussia. La costruzione, approvata lo scorso ottobre dal Parlamento, si estenderà per 186 chilometri, circa metà della lunghezza del confine tra i due paesi, attraversando la foresta vergine di Bialowieza, patrimonio dell’UNESCO dal 1979. Per Varsavia, la barriera servirà ad ostacolare l'ingresso dei migranti provenienti da est ed evitare le tensioni vissute negli scorsi mesi. Il costo dell’operazione è di oltre 350 milioni di euro, circa dieci volte il budget annuale del Dipartimento di immigrazione polacco. Per comprendere meglio le ragioni di tale decisione occorre fare un passo indietro. Lo scorso novembre il confine polacco-bielorusso è stato interessato da un afflusso di migranti senza precedenti, proveniente per lo più dai paesi del Medio Oriente. Le autorità polacche, appoggiate dall’Ue e dalla NATO, hanno rivolto accuse al regime di Lukashenko, reo di aver provocato una crisi umanitaria incoraggiando i flussi migratori verso l’Unione attraverso la facile concessione di visti turistici. Il Governo guidato da Morawiecki, inoltre, ha risposto schierando migliaia di soldati e agenti di polizia armati, allo scopo di bloccare gli attraversamenti irregolari, e costruendo una barriera temporanea di filo spinato. Da qui l’annuncio di issare un muro alto cinque metri e mezzo, dotato di torri di guardia, telecamere e sensori di movimento a protezione dei propri confini e dei confini esterni dell’Unione, i cui lavori termineranno il prossimo giugno. Sebbene i tentativi di oltrepassare la frontiera rispetto alle settimane precedenti siano decisamente diminuiti, tanto da far parlare ormai di numeri ridotti, per gli operatori umanitari la crisi alla frontiera perdura, aggravata da un inverno rigido, che mette a dura prova la sopravvivenza dei migranti. L’imminente costruzione del muro lungo il confine ha generato preoccupazioni non solo sul fronte dei diritti umani. L’avvio dei lavori ha spaccato l’opinione pubblica sollevando dure proteste per l’impatto ambientale che il muro potrebbe avere sulla vegetazione prevalentemente boschiva. La costruzione di cemento, infatti, attraverserà la foresta di Bialowieza, una delle più antiche e meglio conservate d’Europa, con effetti disastrosi sulla fauna selvatica. La foresta, che si estende su una superficie di ben 876 km², appartiene all’immensa distesa verde che un tempo copriva gran parte delle pianure dell’Europa continentale e ospita più di 12.000 specie di animali. Per gli esperti, il danno ambientale arrecato dalle tonnellate di cemento e metallo che verranno riversate nell’area metterà a rischio la sopravvivenza di centina di specie animali e vegetali completamente estinte nel resto del pianeta. Il muro, inoltre, ostacolerà il movimento delle specie presenti, tra cui figurano gli unici esemplari del bisonte europeo. In queste ore, la portavoce della Guardia di frontiera polacca si è affrettata a dichiarare che l’intenzione è provocare il minor danno possibile all’ambiente e che l’abbattimento degli alberi sarà ridotto allo stretto necessario, ma diverse organizzazioni ambientaliste, come Greenpeace e l’ONG Wild Poland, hanno evidenziato che l’ingresso di macchinari pesanti danneggerà inevitabilmente il suolo e la vegetazione del sito UNESCO. Alcuni studiosi della foresta, inoltre, prevedono che i processi di ripopolamento in atto in alcune aree, da parte di diverse specie di animali, verranno interrotti dall’inquinamento sonoro, luminoso e del suolo generato dai lavori. La barriera tra Polonia e Bielorussia va ad aggiungersi alle barriere di cemento o filo spinato che già interessano le frontiere esterne e, addirittura, interne dell'Unione (si pensi al confine tra Austria e Slovenia, entrambi membri Schengen), e ci ricorda come tali muri, nel complesso, producano effetti solo circoscritti sui flussi di persone. Infatti, se da un lato il muro potrebbe rendere più difficile l’ingresso di nuovi migranti in Polonia, dall’altro, occorre considerare che le persone, nonostante le complicazioni, potranno eludere questa barriera semplicemente aggirandola. Stessa cosa, purtroppo, non si può dire per gli animali che abitano la foresta, e il muro al confine USA-Messico ne è un chiaro esempio. Un’iniziativa di questo tipo, inoltre, confligge con le azioni messe a punto per proteggere l’ambiente e contrastare i cambiamenti del clima. La Polonia, poi, in quanto membro dell’Unione contravviene ad un chiaro obiettivo sancito nel Green New Deal europeo: proteggere e preservare la biodiversità. È chiaro che barriere del genere ostacolano le persone molto meno di quanto facciano con la fauna. Per tale ragione, il muro a protezione del confine polacco non eliminerebbe il problema, anzi ne solleverebbe un altro, quello ambientale, danneggiando in modo permanente uno degli ultimi polmoni incontaminati presenti nel continente europeo.
a cura di Elisa Cecchini A trent’anni dalla dissoluzione dell’Unione Sovietica, il Kazakistan è stato travolto da disordini e rivolte popolari. Considerato “un pilastro per la stabilità” politica ed economica dell’Asia centrale, rappresenta un nodo strutturale per le ambizioni economiche della Cina nell’iniziativa Belt and Road, un alleato chiave per la Russia nel progetto di integrazione economica dell’Unione Euroasiatica e un importante partner per l’Unione Europa. Il Kazakistan è stato governato per tre decenni da Nursultan Nazarbayev, già primo ministro della Repubblica socialista sovietica kazaka nel 1984 e presidente del Soviet supremo nel 1990; venne eletto presidente della Repubblica del Kazakistan nel 1991, segnando così la sostanziale continuità con l’epoca sovietica. Negli anni, Nazarbayev creò un regime semi-autoritario, fortemente personalistico, dominato dal partito Nur-Otan. Nel 2019 ha lasciato la presidenza al suo delfino Kassym-Jomart Tokayev, pur mantenendo un ruolo di punta nella politica nazionale attraverso la guida del Consiglio nazionale per la sicurezza. Una volta insediatosi, Tokayev aveva promosso un pacchetto riforme politiche che non si sono mai rivelate sostanziali, mantenendo inalterato lo status quo del potere e contribuendo così a nutrire il malcontento tra la popolazione. Le proteste delle scorse settimane hanno avuto inizio nella città di Zhanaozen, nel Sud-Ovest petrolifero del paese non lontano dal confine turkmeno. La città era già stata teatro di proteste che avevano portato nel 2011 al “massacro di Zhanaozen”: la polizia aveva aperto il fuoco sulla folla di operai petroliferi in sciopero che chiedevano condizioni lavorative migliori, causando la morte di sedici dimostranti e un centinaio di feriti. La regione del Kazakistan che si affaccia sul Mar Caspio è ricca di giacimenti di petrolio, gas ed uranio. Il settore energetico è di vitale importanza per il Kazakistan, con un PIL di 169 miliardi di dollari nel 2020, è lo stato più ricco dell’Asia centrale. Questa ricchezza derivata dai proventi dell’industria petrolifera ha portato all’arricchimento di una ristretta élite di persone, mentre quasi metà della popolazione kazaka vive in condizioni di precarietà, in comunità rurali e con scarso accesso ai servizi pubblici. Si stima infatti che circa un milione di persone su una popolazione di 19 milioni vivano sotto la soglia di povertà. Zhanaozen si trova nel distretto di Mangistau ed è una città mono-industriale, costruita intorno al giacimento petrolifero di Ozen di proprietà della compagnia OzenMunayGas, succursale della statale KazMunayGas. Alla base delle proteste è giusto sottolineare che non c’è solo la frustrazione dovuta a un quadro politico sostanzialmente immutato dagli anni Novanta a oggi, ma anche un disagio economico crescente, che ha portato a un vero e proprio scontro di classe. La scintilla che ha innescato le proteste è stato il rincaro del prezzo del GPL, usato per la maggior parte dei veicoli, che ha raddoppiato in poche ore il suo costo da 60 a 120 tenge al litro. Il governo infatti aveva annunciato la rimozione dei sussidi energetici governativi, passando così alla liberalizzazione dei prezzi, conseguenza della graduale riforma dell’energia avviata nel 2019. A ciò si è aggiunto il mal contento generale per la corruzione endemica dello stato, le difficoltà economiche che sono state aggravate dalla pandemia e l’inflazione galoppante che ha spinto la banca centrale ad innalzare i tassi di interesse al 9,75%. Le proteste si sono diffuse a macchia d’olio da Zhanaozen alle città di Aqtau, Atyrau e Aktobr, fino a dilagare ad Almaty, centro economico del paese, e la capitale Nur-Sultan. La promessa da parte dell’esecutivo di una misura straordinaria per calmierare il prezzo del Gpl è arrivata in ritardo, non risultando efficace nel far placare le proteste. Infatti, le manifestazioni sono continuate sfociando in assalti ai diversi edifici governativi e a saccheggi a banche e negozi. Quello che i manifestanti chiedevano erano riforme politiche, elezioni eque, così da tagliare i ponti per sempre con quel vecchio sistema di potere in piedi da trent’anni sotto la guida dell’ex presidente Nursultan Nazarbayev e della sua famiglia. Il 5 gennaio, dopo aver proclamato lo stato d’emergenza, il presidente della repubblica kazaka Kassym-Jomart Tokayev, ha sciolto il governo e ha fatto dimettere l’ex presidente Nazarbayev dal suo ruolo di capo del Consiglio di Sicurezza Nazionale. Le proteste non si sono sedate e la guerriglia è propagata in ogni angolo del paese, arrivando ad occupare l’aeroporto internazionale e ad abbattere le statue con l’effige di Nazarbayev. Questi eventi hanno spinto il presidente Tokayev a cambiare strategia definendo “terroristi” i manifestanti e richiedendo l’intervento del Collective Security Treaty Organization (CSTO) per arginare le proteste. Il presidente kazako ha giustificato la richiesta d’aiuto in quanto ha definito le violenze frutto di ingerenze da parte di “gruppi terroristici esterni”. Tokayev ha fatto quindi appello all’articolo 4 del Trattato di CSTO, secondo cui “se un membro è soggetto ad aggressione da parte di una forza esterna, è considerata un’aggressione contro tutti gli stati membri”. Questa è stata la prima volta che il CSTO ha autorizzato l’invio di truppe. Il 6 gennaio, 2500 soldati degli stati membri sono entrati in Kazakistan, la maggior parte appartenenti alla quarantacinquesima brigata dell’esercito russo, forze speciali già utilizzate in Cecenia, Ossezia del sud e Siria. Nei giorni successivi, a seguito di un bilancio ufficiale di 168 morti e 8000 arresti, Tokayev ha dichiarato che l’ordine costituzionale fosse stato ristabilito nel paese e ha notificato il ritiro delle truppe del CSTO. Il fatto che Tokayev si sia rivolto all’alleanza militare tra ex repubbliche sovietiche guidate da Mosca riflette la mancanza di sicurezza nel sostegno delle forze kazache al presidente kazako, soprattutto dopo il licenziamento e l’accusa di tradimento di Karim Masimov, capo dell’intelligence e fedele dell’ex presidente Nazarbayev. A maggior ragione dopo aver accusato il suo predecessore Nazarbayev di aver favorito la nascita di una classe elitaria di persone che detengono il potere e le ricchezze del Kazakistan. Sembra ormai chiaro che la famiglia Nazarbayev non sia più una forza politica di primo piano nel Paese.
a cura di Davide Paolicchi Il 24 dicembre 2021 si sarebbero dovute svolgere le prime elezioni “libere e democratiche” della nuova Libia post-Gheddafi. Ma questo non è successo, nonostante le grandi aspettative della vigilia. Tutte le premesse di un fallimento annunciato, però, erano già nell’aria e pienamente comprese da chi si occupa della materia, nonostante si sia poi “accodato” all’unanime auspicio di una soluzione della crisi che dura da circa 10 anni. Eppure, esattamente un anno fa, con le annunciate (poi “congelate” fino a marzo 2021) dimissioni di Fayez al-Sarraj dal Governo di Accordo Nazionale (GNC) – riconosciuto dalle Nazioni Unite - ed il parziale ridimensionamento mediatico della figura di Khalifa Haftar, leader militare della Cirenaica, la situazione sembrava propendere quanto meno verso una dimensione di dialogo. Attraverso la mediazione della Rappresentante Speciale ONU, Stephanie Williams, e l’opera di mediazione del nuovo Primo Ministro ad interim Abdul Hamid Dbeibeh, capo del nuovo Governo di Unità Nazionale (GNU), il processo di pacificazione nazionale (Libyan Political Dialogue Forum) sembrava avere qualche minima probabilità di successo fino all’autunno di quest’anno. Poi però, si sono realizzati i peggiori timori delle cancellerie europee e degli analisti geopolitici, poiché al dialogo è subentrata la confusione su chi avesse la prerogativa di ammettere i diversi candidati, gestire effettivamente le elezioni nei seggi a livello organizzativo, senza dimenticare la garanzia dell’assenza di brogli o ingerenze da parte delle varie fazioni. E un altro problema, di non poco conto, sono i candidati ufficiali; allo stato attuale sono 13, tra cui Dbeibeh, Haftar, e Saif al-Islam Gaddafi, figlio secondogenito dell’ex dittatore libico. L’alto numero di candidati qui sopra esposto evidenzia come ci sia un’evidente frammentazione dello scenario politico libico attuale, oltre che evidenti appoggi esterni da parte di potenze straniere “interessate”. Ed è proprio quest’ultimo punto che ha e sta tutt’ora giocando a sfavore dello svolgimento delle elezioni presidenziali. Infatti, rimangono ancora troppi gli interessi legati alle materie prime della Libia e alla sua posizione geografica, e ogni nazione che ha svolto un proprio ruolo durante gli oltre 10 anni di crisi statuale, ora vuole provare a posizionare le proprie “pedine” all’interno delle istituzioni di vertice di uno Stato che non esiste, né a livello burocratico-organizzativo, né a livello di riconoscimento di affidabilità dall’estero. Proprio la presenza di milizie irregolari, più o meno politicizzate oppure religiosamente ortodosse, sta continuando a minacciare costantemente la sicurezza nazionale, anziché salvaguardare la svolta libica verso un futuro libero. Si aggiunga la questione migratoria, rimasta irrisolta benché coinvolga più o meno direttamente tutte le bande armate libiche che traggono vantaggio dall’enorme massa di migranti che si riversano e vengono quindi resi “schiavi” e sfruttati per ottenere maggiore guadagno e visibilità nei negoziati di questi mesi. E sono quelle stesse milizie che vengono poi “addestrate”, supportate e finanziate ad esempio dall’Italia o da quei paesi con forti interessi in Libia. La stessa richiesta di ritiro (mai effettuata) di tutte le forze militari straniere presenti in Libia ha suscitato i principali contrasti all’interno del processo di pacificazione. Ricordiamo come, oltre all’Italia, nel paese sono ancora presenti consiglieri militari e milizie siriane filo-turche in appoggio a quelle di Tripoli, senza dimenticare i mercenari russi della compagnia militare privata russa Wagner. Proprio l’appoggio esterno e la presenza di una quantità di armamenti forniti alle milizie locali, formatesi ed ingrossatesi per via dell’alto livello di disoccupazione post-rivoluzione, hanno generato la creazione di bande armate fedeli ai propri capi militari o leader politici, i quali stanno tentando in ogni modo di integrarli nelle nascenti forze armate regolari. In questo senso, l’assenza di addestramento omogeneo dato da una missione coordinata e la mancanza di una forza militare di peacekeeping (osteggiata a livello incrociato da tutti gli attori coinvolti) sotto il mandato ONU, negli anni ha portato ad una situazione di stallo che si è sempre cullata nella falsa idea che bastassero dei proclami retorici nazionali per riunire le varie fazioni armate. Proprio l’assenza di una presenza militare di interposizione tra le parti, a “garanzia” del completamento della pacifica transizione politico-elettorale, ha messo in luce la reale mancanza di volontà delle organizzazioni internazionali (ONU), o regionali interessate (NATO, Unione Europea, Unione Africana e Lega Araba), di un impiego a fondo di parte delle proprie risorse per stabilizzare non solo lo Stato libico, ma l’intera area nordafricana. La stessa mancanza sul terreno di forze militari neutrali genera inevitabilmente la “collisione” tra bande armate ed opposte fazioni politich.. E la realtà dei fatti si è notata a poca distanza dal 24 dicembre. Infatti, una milizia riconducibile alla fazione tripolina ha tentato di influire sulle prossime elezioni palesando un’azione di forza verso il hoverno e lo stesso Primo Ministro Dbeibeh. Quindi, come dimostra questo semplice evento, nuovi tentativi di “colpi di Stato” sono dietro l’angolo ed esercitabili da qualunque delle fazioni in lotta. Sullo sfondo, ma sempre presenti all’interno delle pianificazioni diplomatiche delle cancellerie europee, sono le risorse energetiche di cui la Libia è ricca. Nonostante l’inizio “timido” verso la transizione ecologica (quindi energetica) del Vecchio Continente, l’approvvigionamento delle materie prime rimane fortemente collegato alle tensioni mediorientali (Iraq, Siria e Iran su tutti) e nell’Europa Orientale, che rischiano di perdere i loro principali clienti, esclusa ovviamente la Cina. Le recenti tensioni tra Mosca e Bruxelles su Ucraina e Bielorussia stanno facendo ulteriormente comprendere come la “partita energetica” dovrà essere ancora giocata su più fronti, per evitare di rimanere a corto di fonti che nell’immediato sostengono ancora i sistemi industriali dei paesi più sviluppati. Infine, un altro punto che molti analisti avevano compreso da tempo e che ora molti uffici di affari esteri stanno comprendendo, a loro spese, è che vi è una sostanziale incompetenza della classe dirigente libica ed una chiara immaturità politica dell’elettorato dopo circa 42 anni di dittatura. Nonostante l’appoggio pluriennale a bande armate irregolari ed indisciplinate, definite genericamente “forze armate libiche”, l’unico proposito raggiunto dalle varie forze esterne è stato quello di continuare a perseguire i propri interessi: siano essi legati al problema migratorio, di sfruttamento delle materie prime o contrasto al terrorismo. Ma il continuo rischio di rinvii infiniti delle elezioni non può fare altro che generare un ritorno all’instabilità nazionale e permanente stato di conflitto civile, poiché non è la volontà popolare democratica a prevalere, quanto l’avidità e l’istinto di sopravvivenza degli “elementi peggiori” di questo Stato nordafricano così vicino e strategico per l’Italia.
I conti si fanno nel Mar Cinese Meridionale: Pechino risponde all’ambiguità strategica statunitense22/1/2022
a cura di Enrico Bruni La volontà degli Stati Uniti è orientata alla ricerca di una coesistenza con la potenza cinese, piuttosto che all’instaurazione di una nuova “guerra fredda”. Durante il vertice virtuale tra Capi di Stato, concluso martedì 16 novembre, i presidenti Xi Jinping e Joe Biden hanno tentato di aprire insieme un nuovo capitolo nelle relazioni tra le due sponde del Pacifico. Ma se in Cina la possibilità di distensione offerta dal dialogo tra i leader era stata salutata con soddisfazione, gli sviluppi dei giorni successivi tra Washington e Taipei rischiano di vanificare i risultati del summit. Tra i nodi affrontati nelle tre ore e mezza di conversazione, le problematiche di sovranità territoriale connesse alla “questione Taiwan” sono state più volte richiamate dai due leader assieme ai temi di carattere economico e umanitario. Fin dal suo insediamento, il presidente Biden ha esortato Pechino a desistere dalle minacce all’integrità territoriale dell’isola di Taiwan, ponendosi sulla stessa linea del suo predecessore Trump. Sebbene dal 1979 gli Stati Uniti abbiano ufficialmente riconosciuto l’autorità della PRC, trasferendo le proprie delegazioni diplomatiche dall’isola di Formosa alla Cina continentale, la scelta da parte di Washington di mantenere legami militari con Taipei in conformità al Taiwan Relations Act, risalente alla presidenza di Jimmy Carter, è da sempre stata vista da Pechino come un’inopportuna ambiguità. Come in occasione del discorso pronunciato per il centenario della fondazione del Partito Comunista Cinese, il presidente Xi Jinping non ha risparmiato una serie di reprimenda alla condotta statunitense, rimarcando quali siano le posizioni della Cina sull’isola di Taiwan. La sacralità del principio One China e il rispetto dei contenuti dei tre Comunicati Congiunti USA-PRC sono alla base dei rapporti tra i due paesi e garanzia di coesistenza pacifica. La cifra dell’incontro è forse rappresentata dal passaggio in cui il presidente Xi rimarca la volontà del “popolo cinese nella sua interezza” di raggiungere la completa riunificazione della nazione, invitando la propria controparte ad astenersi dal tessere relazioni di qualsiasi tipo con Taiwan. In sede di vertice bilaterale, la risposta del presidente Biden era stata chiara: convenendo in merito alla razionalità delle istanze di Pechino come unico governo legittimo della nazione cinese, Biden ha riaffermato il rispetto della One China policy, ricordando però l’opposizione da parte della sua amministrazione a qualsiasi soluzione unilaterale alla situazione sullo stretto. Non una convergenza, ma un primo tentativo di disgelo letto con ottimismo in entrambi i paesi. Il dilemma della gestione dei rapporti tra le due superpotenze, tuttavia, permane, ben lontano dal ridimensionarsi, ed è proprio sulla condotta americana nei confronti dell’isola di Taiwan che quelle ore di confronto rischiano di rendersi vane. Gli sviluppi di fine novembre sono stati visti in Cina come una retromarcia da parte di Washington: in un editoriale del 4 dicembre, il Global Times punta il dito contro il Segretario di Stato Antony Blinken che durante la Reuters Next conference avrebbe istigato le forze separatiste di Taipei contro Pechino, minacciando “gravi conseguenze” in caso di aggressione all’isola. Questa dichiarazione è suonata come una provocazione a Pechino, ormai confusa rispetto al comportamento dell’amministrazione statunitense dopo la notizia dell’invito recapitato alle autorità di Taipei per il Summit for Democracy, “un potenziale palcoscenico per le istanze di indipendenza dell’Isola”, come ammonito dal portavoce del Ministero degli Esteri cinese Zhao Lijian. A due mesi di distanza, l’ottimismo nato dalla conversazione tra i due leader sembra già essersi trasformato in scetticismo. Con gli Stati Uniti in bilico tra l’imperativo di garantire Taiwan e quello di non provocare il Dragone, la Cina non è disposta ad arretrare rispetto alla politica aggressiva nei confronti del progetto di riunificazione entro il 2046. Che credito dare adesso alle parole di Biden in merito a una concreta volontà di miglioramento dei rapporti sino-statunitensi? Se dichiarazioni come quella di Blinken rientrano all’interno di una precisa strategia della tensione utile ai rapporti con alleati come Australia e Giappone, la Cina ha già esplicitato di non avere intenzione di tollerare ingerenze straniere in quella che considera una questione interna. Possiamo dire che se l’obbiettivo era quello di generare una de-escalation delle tensioni, l’anarchia diplomatica generata dall’ambiguità strategica statunitense su Taiwan ha riportato Pechino ai giorni di Anchorage.
Deterrenza allo spillover terroristico: come cambia la Cina di fronte agli sviluppi in Afghanistan30/12/2021
a cura di Enrico Bruni A seguito del deterioramento dei rapporti sino-sovietici, negli ultimi decenni dello scorso secolo la Repubblica Popolare Cinese ha gradualmente posto maggiore attenzione alla situazione sul confine afgano. Sebbene esso rappresenti il confine più circoscritto dello Stato cinese, le autorità hanno fin da subito riscontrato un potenziale pericolo per la propria sicurezza nazionale in quella che appariva come una riproposizione della politica Breznev al di là dei confini asiatici. All’indomani della penetrazione sovietica nei territori afghani nel dicembre 1979, l’obbiettivo da parte di Pechino si concentrò sul limitare le mire egemoniche dell’imperialismo sovietico in Asia Centrale, sfruttando la resistenza degli autoctoni per contenere le mire di Mosca. Pechino, del resto, si trovava ad affrontare in quel momento una seconda crisi al di fuori dei propri confini: nel febbraio dello stesso anno, infatti, la RPC si era attivamente impegnata nel conflitto cambogiano-vietnamita a fianco della Kambuchea Democratica, in quello che si impose come uno scontro tra opposti marxismi, a trazione cinese – da un lato – e russa – dall’altro. Così l’Esercito Popolare di Liberazione fu coinvolto nell’addestramento dei ribelli afgani, svolgendo da una parte il ruolo di alleato strategico di Washington, dall’altra quello di interlocutore credibile con i mujahidin afgani, con l’obbiettivo di dissuaderli dal tessere rapporti con le forze separatiste di etnia uigura che operavano nei territori dello Xinjiang. Con la ritirata delle truppe sovietiche dieci anni più tardi, le preoccupazioni da parte di Pechino non cessarono a causa dell’imminente guerra civile e della conseguente anarchia nel mercato di armi e droghe che aveva il suo centro in Afghanistan. Negli anni ’90 il governo cinese fu costretto a ricalibrare la propria diplomazia nei confronti dello Stato talebano, in quanto la strategia di isolamento delle cellule uigure non aveva avuto l’effetto desiderato: l’Afghanistan del Mullah Omar era divenuto infatti terra di rifugio per combattenti stranieri e la Cina vedeva adesso al di là del Corridoio del Wakhan una possibile base di lancio per attentati terroristici sul proprio suolo. Dopo gli avvenimenti dell’11 settembre l’esigenza di una campagna internazionale contro il terrorismo si fece sempre più forte. Temendo quello che potremmo definire un effetto spillover del terrorismo internazionale, Pechino si allineò alla volontà statunitense di risolvere definitivamente la “questione islamica”. Così il dialogo sino-statunitense, iniziato con la concessione del voto cinese alla Risoluzione 1368 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sull’autorizzazione all’uso della forza, si concentrò sull’individuare strategie coordinate per la deterrenza al terrorismo. È in questo contesto internazionale che vengono rafforzate legislazioni domestiche come la Strike Hard Campaign: varata nel 1996 come operazione di polizia di portata nazionale, questa si vide proiettata sui più complessi scenari del terrorismo transnazionale, accentuando la sua accezione di “hard campaign” a fronte di episodi di violenza che miravano ad alterare determinate politiche statali in particolari aree geografiche dove erano presenti minoranze, prima tra tutte lo Xinjiang. Sul versante regionale, invece, la situazione in Asia Centrale consolidò i rapporti tra i paesi che avevano aderito al meccanismo di cooperazione multilaterale Shanghai Five (1996), concorrendo in tal modo alla sua trasformazione nello Shanghai Cooperation Organisation all’inizio del nuovo millennio. La Cina si interfacciò, inoltre, come partner strategico per tutti quei paesi con cui condivideva interessi in sviluppo economico e sicurezza interna, promuovendo nuovi accordi bilaterali di cooperazione con gli Stati confinanti. Oggi, dopo la caduta del National Unity Government dell’Afghanistan e la conseguente decadenza di quegli impegni internazionali sul tema della deterrenza concordati da un rinnovato rapporto sino-afgano, le autorità della RPC valutano gli sviluppi regionali in Afghanistan con grande attenzione, proponendo una diversa visione di “stabilità” rispetto a quella americana. Se da una parte la Cina deve fare i conti con le ambizioni di Pakistan e Russia, dall’altra parte la propria posizione è ben diversa rispetto a quella degli anni ’80 e il ruolo che può oggi esercitare non si limiterà alla sola strategia di contenimento applicata durante la penetrazione sovietica. L’obbiettivo resta quello di stabilizzare i propri confini e la propria sicurezza interna, in linea con quella che è la “regola aurea” della diplomazia cinese: il principio di non ingerenza. In questo quadro, tuttavia, la volontà di Pechino non è soltanto strategico-militare. A fianco al desiderio di un Afghanistan stabilizzato e cooperativo, la possibilità di allontanare le autorità afghane dall’area di influenza statunitense apre nuove prospettive per lo sviluppo di infrastrutture lungo la rotta terrestre della Belt and Road Initiative. L’elemento di novità rappresentato dall’unicità di un rinnovato Stato talebano pone la Cina di fronte alla possibilità di ampliare ulteriormente la propria sfera di influenza regionale. Ciò le consentirebbe non soltanto di alterare gli equilibri regionali a scapito di India e Pakistan, ma anche l’accesso alle risorse minerarie presenti nel sottosuolo afghano, particolarmente interessanti nella contesa per il primato sulle terre rare.
a cura di Gianluca Maglione Il 9-10 dicembre è andato in scena il “Summit for Democracy”, pensato da Joe Biden nel corso della campagna presidenziale allo scopo di rilanciare la leadership statunitense in tema di diritti e porre un argine all’avanzata dei regimi autoritari nel mondo. L’iniziativa - che ha riunito intorno ad un tavolo virtuale ben 110 paesi, protagonisti della società civile, media e dissidenti – ha rappresentato l’occasione per compattare il fronte democratico, chiamando a raccolta i paesi pro-USA, e riabilitare l’immagine statunitense a seguito degli eventi del 6 gennaio 2021. Al termine delle due giornate di incontri, il vertice ha fatto parlare di sé non tanto in relazione agli impegni assunti, quanto alla lista dei partecipanti stilata dalla Casa Bianca. L’elenco, infatti, ha generato non poche perplessità alla luce degli standard democratici di alcuni invitati, sollevando critiche tra gli esclusi e imbarazzi tra i presenti. Il criterio adottato da Washington è parso piuttosto ambiguo, segnalando la volontà di coniugare ragioni ideologiche, come la lotta all’autoritarismo, ad interessi più strettamente geopolitici. Tra le grandi escluse, neanche a dirlo, hanno figurato Cina e Russia, principali antagoniste di Washington per la supremazia globale, che si sono affrettate a criticare l’iniziativa statunitense. Il Summit lanciato da Biden ha avvicinato Pechino e Mosca che, attraverso un editoriale apparso sul The National Interest, firmato dai rispettivi ambasciatori a Washington, hanno definito il vertice un prodotto della mentalità statunitense da Guerra Fredda, in riferimento all’appello lanciato da Biden nei mesi precedenti allo scopo di chiamare a raccolta il “mondo libero”. Dal canto suo, Pechino, in un documento intitolato "Cina: la democrazia che funziona", ha ribadito che non esiste un modello predeterminato di democrazia, criticando la definizione imposta dall’Occidente ed esaltando la democrazia cinese attenta agli interessi del popolo. Nel frattempo, la propaganda di Stato si è data da fare nel tentativo di minare l’iniziativa diplomatica della Casa Bianca, irritata dall’invito di Taiwan, considerata una provincia ribelle da riunificare al continente. Tra i membri della NATO escluse eccellenti sono state l’Ungheria, unico paese dell’Unione Europea al quale non è stato esteso l’invito - suscitando l’evidente imbarazzo di Bruxelles e la reazione dell'ambasciata ungherese a Washington - e la Turchia di Erdoğan, protagonista da tempo di una svolta in senso autocratico. Di contro, nella lunga lista di invitati hanno figurato paesi quali Angola, Filippine, Iraq, Pakistan, per citarne alcuni, che mostrano indici di democrazia decisamente scarsi. Circa il 30% di questi, infatti, occupano saldamente gli ultimi posti della classifica compilata annualmente da Freedom House, etichettati come “parzialmente liberi” o, persino, “non liberi”. È forse per tale ragione che Biden - consapevole dei discutibili indici democratici di alcuni paesi invitati - abbia parlato di un incontro “per la democrazia” e non di un summit “di democrazie”, avendo cura di evitare qualsiasi riferimento a motivazioni di carattere strategico. Alla luce degli eventi di Capitol Hill, peraltro, viene da chiedersi se gli stessi Stati Uniti siano attualmente nella posizione di guidare la leadership democratica globale, dal momento che uno dei due maggiori partiti si rifiuta di accettare i risultati delle ultime elezioni presidenziali, ritenendole illegittime. Nel proprio intervento, Biden non ha dimenticato di rimarcare come alcune libertà, in particolare quelle di voto, vengono minacciate anche nel suo paese, denunciando le difficoltà del sistema americano. Il riferimento è alle pratiche di alcuni Stati a guida repubblicana che hanno approvato leggi per ostacolare i diritti di voto dei più poveri e delle minoranze. A vertice concluso (passato piuttosto in sordina) resta da domandarsi, dunque, quali e che tipi di risultati abbia prodotto. Dal punto di vista degli impegni assunti, il Governo statunitense ha rivendicato il proprio ruolo guida varando un piano di 424,4 milioni di dollari in aiuti esteri, ribattezzato Presidential Initiative for Democratic Renewal. I fondi, che passeranno dall’approvazione del Congresso, saranno destinati a supportare media liberi e indipendenti, contrasto alla corruzione, sostegno alle riforme in senso democratico e installazione di sistemi tecnologici avanzati per la democrazia. Dal punto di vista dei rapporti globali, invece, l’iniziativa statunitense ha indubbiamente esacerbato lo scontro con le cosiddette “autocrazie”, che hanno visto il vertice un chiaro tentativo della Casa Bianca di perseguire interessi più ampi, facendo leva sulla retorica democratica. Infatti, se la difesa della democrazia è al vertice dell’agenda statunitense, la partecipazione al Summit di alcuni paesi è apparsa piuttosto singolare, segnalando obiettivi che trascendono il rafforzamento della stessa. Nei mesi a venire, quindi, la credibilità dell’amministrazione Biden dipenderà dalla capacità di coniugare la promozione dei principi del “mondo libero” con il perseguimento di interessi strategici, che legano inevitabilmente gli Stati Uniti, e più in generale l’Occidente, a paesi lontani dall’essere società aperte, pluraliste e rispettose dei diritti umani. Inoltre, alla luce delle sfide globali come la pandemia, l’inquinamento, la transizione ecologica - che richiedono l’impegno dell’intera comunità internazionale, e specialmente di due attori importanti come Russia e Cina - sarà necessario evitare il ricorso a logiche che distinguono paesi “buoni” e “cattivi”, determinando effetti controproducenti.
EU global gateway: la sfida verde dell’Unione europea alla Belt and Road Initiative cinese21/12/2021
A cura di Lorenzo Borghi, Osservatorio sull'Unione europea
Il 1° dicembre 2021 la Commissione europea, nella persona dell’Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha approvato il “Global Gateway” (GG). La nuova missione di politica estera europea prevede un ingente investimento di 300 miliardi di euro che verrà sfruttato per progetti inerenti un’interconnessione intelligente, pulita e sicura in materia digitale, energetica e di trasporti, nonché per un potenziamento dei sistemi sanitari, dell’istruzione e della ricerca e sviluppo in tutto il mondo. Tutti questi investimenti e progetti dovranno essere effettuati nel periodo temporale tra il 2021 e il 2027. Dopo l’approvazione del NextGenerationEU e, quindi all’onere di elargire prestiti a fondo perduto e non agli Stati membri, l’Unione europea (UE) finanzierà il progetto del Global Gateway tramite nuovi strumenti finanziari: The Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (NDICI)-Global Europe, Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA) III, European Fund for Sustainable Development+ (EFSD+). Inoltre, dei 300 miliardi, circa 18 verranno prelevati dal bilancio dell’Unione sottoforma di sovvenzioni; invece, fino a circa 145 saranno messi a disposizioni dalle istituzioni finanziarie europee e dalle istituzioni europee per il finanziamento allo sviluppo. In aggiunta, l’UE pare intenzionata a istituire uno Strumento europeo per l’accredito all’esportazione. L’azione esterna europea verterà principalmente sul rispetto delle linee guida emerse dai comunicati finali del G7 di giugno 2021 e della COP26 di Glasgow. Infatti, per quanto riguarda il primo, l’impegno europeo si baserà in interventi infrastrutturali trasparenti, fondati su standard e valori elevati. Per quanto concerne la COP26, invece, gli investimenti infrastrutturali dovranno rispettare lo sviluppo sostenibile tramite infrastrutture pulite, resilienti e coerenti con un futuro a zero net emissions. Per l’appunto, a sostegno di questa missione internazionale è intervenuta direttamente la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, dichiarando: “La pandemia di COVID-19 ha dimostrato quanto sia interconnesso il mondo in cui viviamo. Nel contesto della nostra ripresa globale vogliamo ridefinire il nostro modello di connessione mondiale, per poter plasmare più efficacemente il futuro. Il modello europeo prevede di investire sia nelle infrastrutture materiali che in quelle immateriali, di favorire investimenti sostenibili nei settori digitale, climatico ed energetico, nei trasporti, nella sanità, nell'istruzione e nella ricerca nonché in un quadro favorevole che garantisca condizioni di parità. Sosterremo investimenti intelligenti in infrastrutture di qualità, rispettando le più rigorose norme sociali e ambientali, in linea con i valori democratici dell'UE e con le norme e gli standard internazionali. La strategia "Global Gateway" fungerà per l'Europa da fonte d'ispirazione nella costruzione di connessioni più resilienti con il mondo.”. Ad ogni modo, osservando politicamente il GG europeo, emerge come esso possa diventare nei prossimi sei anni lo strumento di politica estera europea per contrastare l’avanzata cinese della Belt & Road Iniziative (BRI) sugli interessi geopolitici degli Stati del Vecchio Continente. L’obiettivo principale UE è quello di recuperare il divario a livello d’influenza economica e politica, venutasi a creare dal 2013 per via della Nuova Via della Seta di Xi Jinping, in Paesi non comunitari quali quelli dell’indo-pacifico, dell’Africa, dell’Oceania e dei Balcani. La volontà dell’UE è quella di proporre un modello, rispetto a quello cinese, di investimenti alternativo e più trasparente per cercare di coinvolgere un numero sempre più elevato di stati dubbiosi dello schema cinese e delle sue politiche di condizionalità. Analizzando i costi totali delle due politiche estere, però, emerge come i 300 miliardi di euro europei non potranno contrastare gli attuali circa 600 miliardi di dollari investiti dal governo cinese sino ad oggi e, peggio ancora, i 2/8 “triliardi” di dollari totali previsti per il completamento della BRI. Di conseguenza, per l’UE la soluzione prioritaria sarebbe quella di occuparsi del vicinato, evitando che i Paesi dei Balcani si allineino ulteriormente con la Cina. Infatti, l’acquisizione delle quote maggioritarie del Porto del Pireo da parte della società cinese COSCO è solo il punto di partenza di espansione nell’area dei Balcani da parte del governo di Pechino: l’obiettivo è quello di collegare il Pireo e i Paesi balcanici tramite il finanziamento cinese del progetto dell’alta velocità ferroviaria tra Budapest e Belgrado. Qualora dovesse realizzarsi, significherebbe garantire alla Cina una corsia preferenziale per i propri prodotti nell’Europa centro-orientale, destabilizzando le mire geopolitiche ed economiche dell’UE e anche della Russia, che da secoli si contendono l’area. In ultima analisi, il progetto Global Gateway promosso e approvato dalla Commissione europea è un piano volto a riproporre l’Unione come modello alternativo a quelli due principali potenze attualmente presenti nello scenario internazionale: Cina e Stati Uniti. Con quest’ultimi, infatti, si prospetta una serrata cooperazione assieme al loro nuovo progetto internazionale “Build Back Better World”. Infine, invece, per quanto riguarda la sfida indirettamente lanciata alla Cina, come già precedentemente evidenziato, gli effetti saranno solamente quelli di rallentare l’avanzata cinese e difficilmente quella di sfidarli apertamente nel campo degli investimenti. Le differenze dei budget messi a disposizione confermano questa tesi. Per questo motivo, l’UE sicuramente avvierà nuovi dialoghi con vari attori internazionali proveniente da diversi continenti, ma cercherà di consolidare e stabilizzare primariamente e preferenzialmente il continente europeo. BIBLIOGRAFIA
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||